
L’Eros di Piccadilly Circus, Londra
Chi l’avrebbe mai detto: «…povero, sempre; e non è affatto delicato e bello, come per lo più si crede; bensì duro, ispido, scalzo, senza tetto; giace per terra sempre, e nulla possiede per coprirsi; riposa dormendo sotto l’aperto cielo nelle vie e presso le porte».
Bel ritratto, eh, quello di Eros fatto da Diotima nel Convito di Platone. Il fanciullo è infatti figlio di Penia, la Povertà, che va a mendicare al banchetto in onore della nascita di Venere e si fa venire la brillante idea di giacere con Poros, l’Espediente.
E ci riesce, anche perché lui è ebbro di nettare («vino ancora non ce n’era»).
Da questa coppia così bene, o male, assortita nasce il dio dell’Amore, certo il primo e il più importante dei sentimenti.
Dunque, cominciamo da lui.
 Non pensavo che fosse difficile.
Non pensavo che fosse difficile. Al mio stadio di jeune fille en fleur, mio e delle mie amichette, l’ostacolo più impervio da superare era costituito dalla vigilanza materna. Le madri erano carceriere, torturatrici, badesse di convento, tutte pronte sempre a proibire qualunque anelito di libertà e a esercitare un controllo paranoico sull’esistenza di noi povere figlie.
Al mio stadio di jeune fille en fleur, mio e delle mie amichette, l’ostacolo più impervio da superare era costituito dalla vigilanza materna. Le madri erano carceriere, torturatrici, badesse di convento, tutte pronte sempre a proibire qualunque anelito di libertà e a esercitare un controllo paranoico sull’esistenza di noi povere figlie.

 Ammetto di aver passato giorni fa mezza serata a cercare nel mio calice di Falanghina, girandolo e rigirandolo da tutte le parti, i «luminosi riflessi verdolini» di cui parlava la scheda del sito di acquisizione.
Ammetto di aver passato giorni fa mezza serata a cercare nel mio calice di Falanghina, girandolo e rigirandolo da tutte le parti, i «luminosi riflessi verdolini» di cui parlava la scheda del sito di acquisizione.
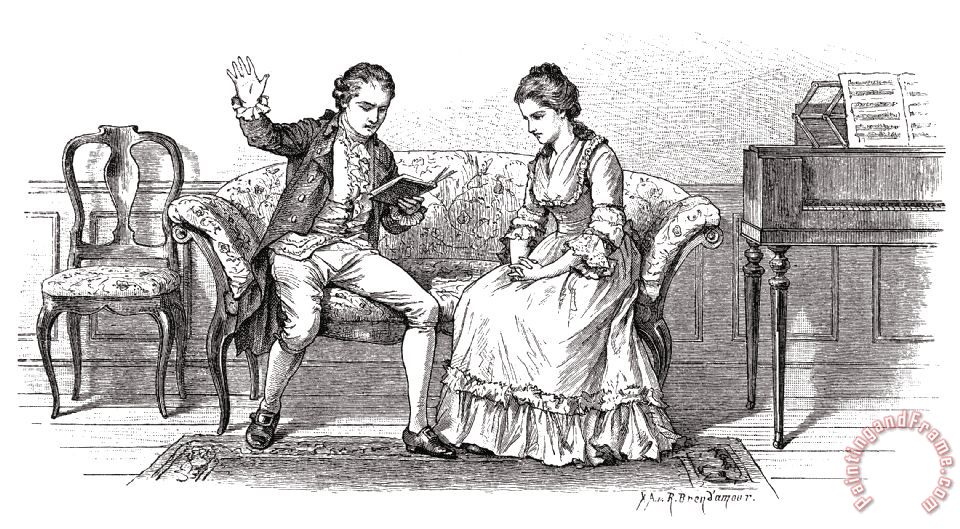

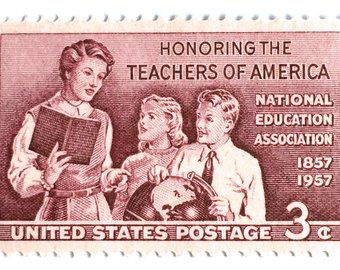 L’aula non è nemmeno del tutto male.
L’aula non è nemmeno del tutto male.