
Jane Campion, Bright Star, 2009
Bright star! Would I were steadfast as thou art-
Not in lone splendour hung aloft the night…
(Oh fossi come te, lucente stella,
costante – non sospeso in solitario
splendore in alto nella notte…)
John Keats, Bright Star
Sono andata a scuola quando la scuola era una cosa solida e affidabile.
Certo, non perdonava, in quarto ginnasio eravamo trentadue studenti e in quinto, sedici.
Al 50% degli iscritti fu detto chiaramente di cambiare aria.
Comunque a me la scuola ha dato tantissimo, certi giorni penso che mi abbia dato tutto.
Non riesco a ricordare quando la scuola mi ha dato John Keats, se fu alle medie o al ginnasio, ero ragazzina, ma non mi ricordo quanto.
Pensai subito però che mi fosse destinato.
Saputo che il poeta era venuto a Roma in cerca di un clima migliore e aveva abitato a piazza di Spagna, feci un primo passo e andai a vedere la sua casa.
Poi seppi che lui era morto qui a venticinque anni e che era sepolto al Cimitero che chiamiamo degli Inglesi.
Un giorno dunque presi il tram da Prati e andai fino a Testaccio, in un viaggio che nel mio immaginario avrei paragonato in seguito a quello di Ada, dalla Scozia alla Nuova Zelanda.
Pensai che il Cimitero era il luogo più romantico che avessi visto.
E lo penso ancora oggi, con tutti i cimiteri e i luoghi romantici che ho visto in vita mia.
Dunque, l’intuizione fu esatta e la relazione fu da subito intensa.

Roma, Cimitero detto degli Inglesi, tombe di John Keats (a sin.) e dell’amico Joseph Severn
Allora, si fa così.
Avendo io la regola di non entrare mai in contatto reale con gli scrittori che prediligo e di mai fare niente di analogo nel cinema e nell’arte in genere, quando uscì il film di Jane Campion dedicato a Keats, che prende il titolo dall’incipit di una delle sue poesie, pensai e adesso che faccio, come niente il mito si incrina.
E invece.
Ecco un poeta.
Autentico: inglese di Londra, romantico, padre stalliere, che aveva sposato la figlia del padrone, madre morta di tisi, fratello morto anch’egli nello stesso modo.
Senza denaro e pieno di debiti.
Vocazione che lo coglie a quindici anni.
Vita breve, tormentata.
Un amore per una giovane donna, che poi è la vera protagonista del film, è lei la Bright Star.
Fanny Brawne è una ragazza di carattere, che vuole fare la stilista, guadagnandosi da vivere con questa professione.

Fanny
È una con le idee chiare, anche piuttosto disinvolta per l’epoca.
È innamorata e questo sentimento la ricolma e la definisce.
Il film è un florilegio di versi di Keats e, insieme, una riflessione sull’amore-passione: che fa male, per la lontananza, l’attesa di una lettera, che si infiamma nella vicinanza, che crea un mondo a parte, che accompagna per tutta l’esistenza.
Morto lui, vediamo che lei si veste completamente di nero, si taglia i capelli e la seguiamo mentre cammina in un bosco. Una didascalia ci dice che avrebbe continuato a camminare lì per tutta la vita, a volte anche di notte, e che mai si sarebbe sfilata dal dito l’anello che lui le aveva dato.
Chi dice che il tempo guarisce, sbaglia.
Almeno, il tempo non guarisce l’amore.
Con tutta questa materia incandescente, con la leggenda, i versi, le atmosfere della campagna inglese, la pioggia, la neve, le estati brevi, la malattia che si dichiara improvvisamente e violentemente, il circolo dei poeti, le amicizie proprio come uno se le immagina, giornate trascorse a discutere su una pagina, riunioni con in mano una tazza di té (il laudano non si vede, evidentemente era servito a parte), con tutta questa panoplia di favole e di chimere, i rischi erano tanti.
Invece, niente.
La regista ha la mano sicura, delicata, misurata, stavolta sta senza sofferenza alcuna nello scorrere del tempo, capiamo che sono passati i giorni e che sono passate le settimane perché ce lo dice uno scambio verbale, per noi tutto è fluido, non ci sono scossoni.
Se non, ovviamente, quelli che ci scuotono davanti all’impossibilità di questo amore.
Ma non è la rabbia che ti prende nella Traviata quando Violetta, tisica anche lei, accetta di non vedere più Alfredo perché glielo chiede il padre di lui, e pure Arbasino una volta scrisse «Digli di no», che è quello che pensiamo tutti, ma mettilo alla porta, ma lascialo perdere.
No, qui siamo circa trent’anni prima, in un momento in cui il denaro, che nell’opera di Verdi è al centro di tutto, è un attributo interessante ma non sostanziale.
Che ci fai con i soldi, se sei un giovane poeta dal forte sentire.
E se poi non puoi sposare la donna che ami per questo motivo, ciò fa parte della tua vicenda personale, puoi sempre scriverci sopra una poesia.
Il film è struggente, formalmente perfetto, inondato di luce, colmo di citazioni d’arte.

Fanny
La presenza di Jan Vermeer sembra fissa.
Per la luce, ovviamente, ma anche per gli spazi domestici, netti, definiti, accoglienti, per il continuo scambio di biglietti e lettere, tutto un sistema di comunicazione che ti fa sembrare i messaggi di oggi una cosa povera e sciatta.
(Poi, che c’entra, dipende da quello che ci trovi scritto).

Jan Vermeer, Ragazza che legge una lettera, 1659
Come abbiamo già detto, Jane Campion conosce molto bene la storia dell’arte e la percorre a suo piacimento, ne tira fuori il meglio, tu guardi i suoi film e ti chiedi come possa un regista ignorare il più diretto precedente di tutto ciò in cui consiste il suo lavoro.
E lei non esita nemmeno davanti al più totale spaesamento, per cui ecco come cita Edward Hopper, trasferendolo in un contesto culturale diverso e cambiando di segno ai sentimenti espressi.
La solitudine moderna dell’americano; il vagheggiamento amoroso trasferito sulla stilista inglese della neozelandese.

Fanny

Edward Hopper, Morning Sun, 1952
I costumi sono un capitolo a parte.
Janet Patterson, australiana, scomparsa, come si dice, prematuramente, è la migliore alleata di Jane Campion.
Già fare il costumista per il cinema è uno dei lavori più divertenti che ci siano, studi, inventi, crei e ri-crei.
Poi, quando devi creare gli abiti di una che vuole fare la stilista, il divertimento si eleva al quadrato, insomma, avete presente quando si dice mettersi nei panni di qualcuno.

Janet Patterson per Fanny
E che ci sia divertimento, ovvero gusto nel lavoro, è evidente.
Fanny cuce continuamente, lei si esprime attraverso l’ago, il filo e la stoffa, ricama un cuscino per Tom, il fratello di Keats, appena morto, sul quale appoggiare la sua testa, trova un buco in un abito di John, dice che la giacca non ha più la fodera e che vuole sostituirla.
Nel frattempo aveva già sottratto alla sorellina un nastro per decorare il cestino dei biscotti da portare al moribondo.
E il cestino doveva essere bellissimo.
Una parola anche per la già citata sorellina.

Toots
I bambini di Jane Campion sono deliziosi e Toots non viene meno al patto: rossa di capelli, pelle di porcellana come una bambola, sempre pronta a dare una mano e ad andarci di mezzo nei momenti di umore storto, è visibilmente innamorata pure lei di Keats e appena può glielo dimostra.
Capacità magistrale di far recitare i bambini come se fossero tali, non quegli esseri indisponenti e petulanti del nostro cinema.
Ma lui, lui com’è.
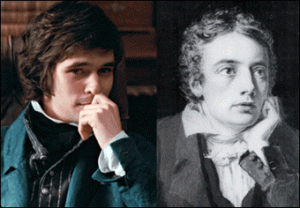
John & John
La grande, assoluta e totale domanda.
Lui è perfetto.
Lui è esile, tormentato, ha le unghie tagliate male e orlate di nero, ha «una fibra delicata e predisposta alla tisi», come scrive Mario Praz, il più grande anglista italiano di ogni tempo, che secondo me, essendo lui un esteta consumato e un appassionato d’arte, avrebbe molto apprezzato il film.
John Keats incarna alla perfezione nel film il fantasma (uno dei fantasmi, d’accordo) di ogni donna: quello di incontrare sui propri passi un poeta romantico, malato e senza soldi che le dia l’ambizione di guarirlo.

John
Resta che poi le cose andarono per lui diversamente, anche se la sua eredità, l’eredità di uno morto così presto, avrebbe innervato e nutrito l’arte dei secoli successivi.
Non sto nemmeno a citare le sue opere che avrebbero offerto ai Preraffaelliti, anche a quelli fuori tempo massimo, quindi, ancora più sensuali e decorativi, la materia prima per la loro pittura, da Isabella, a The Eve of St. Agnes, alla ballata La Belle Dame sans Merci.

John William Waterhouse, La Belle Dame sans Merci, 1893
Resta che se non conosci e non ami John Keats, non capisci niente di storia dell’arte e guardate che non sto parlando solo dell’arte di quel periodo.
Il film finisce in una sobrietà e in un rigore che tutto saldano.
In una piazza di Spagna deserta, in una Roma che stavolta non sembra finta (e che finta non è, i titoli di coda lo dicono chiaro e forte), la bara del giovane poeta inglese viene messa su un carro funebre che di fastoso non ha proprio niente.
È il 23 febbraio del 1821.

Lo sanno tutti (ma sarà poi vero), ma lo ripeto.
Sulla tomba di John Keats non c’è il suo nome, c’è solo l’iscrizione che egli stesso si era scelta: «Here lies one whose name was writ in water», «Qui giace uno il cui nome fu scritto sull’acqua».
Noi apprendiamo qual è quel nome dalla tomba vicina, quella dell’amico pittore John Severn.
Che ha la tavolozza e che si definisce «devoted friend and death-bed companion of John Keats», ovvero amico devoto e compagno sul letto di morte di.
Se passate a piazza di Spagna o al Cimitero cosiddetto degli Inglesi, andate a porgere il vostro omaggio al poeta.
A pensarci bene, come avrebbe potuto Jane Campion, neozelandese che aveva girato in Inghilterra, non venire a Roma: fosse pure per una sola scena, quella finale, che dura meno di un minuto.
Ma, volete mettere.
Non l’ho letto da nessuna parte, quindi la mia è solo un’intuizione. Ma figuriamoci se lei non è andata anche a raccogliersi sulla tomba di John Keats.
(Proprio come faccio io da quando ero ragazzina, non ricordo quanto).
Altrimenti, come avrebbe potuto, lei, realizzare questo capolavoro.
(E io, nel mio piccolo così piccolo, porgere sul mio blog il mio omaggio a uno dei più tenaci e teneri dei miei teneri e tenaci amori).

Fanny & John